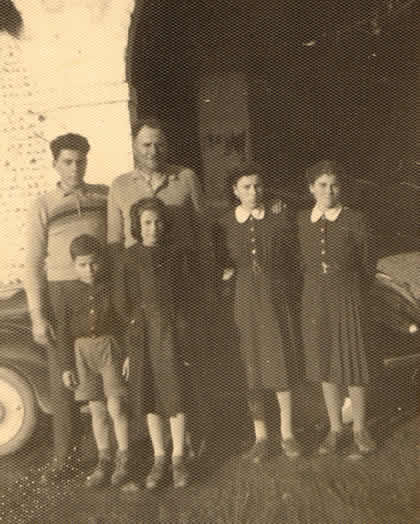 “Settembre, andiamo. È tempo di migrare…”. Così Gabriele D’Annunzio metteva in rima la transumanza, quando le greggi scendevano dalla montagna per il sopraggiungere dell’autunno. La transumanza si esercitava anche nel Veneto. Il mestiere di mandriani negli anni del dopoguerra lo praticavano stagionalmente pure i Gallina di Padernello quando con altri compaesani, accompagnavano gli armenti fino ai verdi pascoli di Malga Mariech (m. 1502), sopra Valdobbiadene. Emilio Gallina e il figlio Germano, poco più che tredicenne, con Gioachino e Augusto Bavaresco, e Arturo Rossi detto “Méto Nardo” partivano a metà del mese di maggio prima dell’albeggiare e s’incamminavano lestamente con le mucche in fila indiana, circa una ventina di capi, verso Vidor e S. Pietro di Barbozza. Qui solitamente sostavano per evitare che con le ore più calde gli animali si sfiancassero. A notte fonda, lasciata la polverosa strada, s’incamminavano per l’erbal fiume silente che conduceva ai pascoli di Pian Fernet. L’uso delle malghe era barattato con il latte. Due vacche erano destinate allo scopo: produrre per pagare l’affitto ai Gallina di S. Pietro di Barbozza, forse lontani parenti di quelli insediati nella campagna di Padernello. All’alpeggio si andava per risparmiare il foraggio di casa che si doveva far bastare nei mesi invernali, ma anche per la salute delle bestie che, mangiando erba e fiori in un clima salutare, si rinvigorivano e producevano un latte che era un vero nettare. Lì si udiva solo il ruminare con il suono stonato ma rilassante dei campanacci. Il mestiere di transumante richiama il nomadismo ed è antico come il mondo. Un tempo la pastorizia era un fenomeno molto diffuso anche nelle montagne venete. La caseificazione avveniva nelle malghe, accendendo il fuoco nel focolare sul quale, immerso nel fumo, stava un enorme pentolone di rame. Era una vita di sacrificio ma salutevole oltre che un’esperienza di buona convivenza. A settembre si discendeva per il tratturo antico, che da queste parti si chiama tròdo (sentiero). Ora il vivere spasmodico ha soppiantato anche questa pratica, ma la nostalgia che fece dire al D’Annunzio “Ah, perché non son io co’ miei pastori?”, quella sì… rimane ed è attualissima. Ogni inverno scendeva da Lamon un impagliatore ben noto in casa Gallina, che rimetteva a nuovo le seggiole. Girovagava per tutte le case della zona prestando la sua straordinaria manualità. Nel primo dopoguerra arrivavano anche tanti mendicanti che trovavano da pernottare nell’umido tepore della stalla adagiati sulla paglia. Non erano degli ignoranti; raccontavano tanti aneddoti ed esperienze di vita di paesi che sembravano tanto lontani; storie di guerra, di fatiche, di malattie, di disgrazie e di povertà estrema. Avevano tuttavia molta dignità e anche qualche speranza di mutare la loro condizione. Mangiavano patate e fagioli, cibi poveri ma nutrienti serviti con amorevole cura dalle donne dei Gallina, perché il buon cuore ai contadini non è mai mancato. Una sera del 1944 accadde un fatto drammatico: irruppe nella stalla dei Gallina una ventina di partigiani comandati da un certo capitano “Merlo”, trascinando due malcapitati con le mani legate dietro la schiena, prelevati nell’osteria di “Piero dea Ida” a Paese. Si trattava di un commissario fascista e di un certo “Mandolino”, così chiamato perché accompagnava le allegre cantate suonando l’omonimo strumento. Era uno sfollato da non si sa quale località del fronte, che aveva trovato accoglienza nella sala parrocchiale, di fronte alla chiesa. Andava per le osterie a suonare e cantare in cambio di qualche spicciolo. Forse nel suo repertorio aveva inserito canzoni trasgressive nei confronti della resistenza. Fatto è che nei confronti dei due, mentre gli uomini della famiglia invasa si dileguavano per i campi, nella stalla fu istituito un sommario processo e alla fine un combattente lesse la sentenza. Di morte. Da eseguirsi seduta stante. Durante le pause della lettura, per enfatizzare la drammaticità della circostanza, qualcuno caricava l’arma dando dei colpi secchi, facendo sobbalzare i due disgraziati. In casa era rimasta la sola moglie di Emilio Gallina, Rita Michelin, con i quattro figlioletti. Saputo che volevano fucilarli nella stalla, si precipitò avventatamente dalla cucina affrontando a viso aperto l’intera compagnia, diffidando i partigiani dal commettere quello che considerava un delitto. Cercò anche delle attenuanti per i due, come fosse il loro avvocato. Considerata l’impavida insistenza della donna, che aveva a fianco il figlioletto Germano di dieci anni, piangente, ipotizzavano di fucilare i due sul cortile sotto il secolare gelso e poi gettare i corpi nella vasca del percolato. Ancora una volta Rita si oppose e insistette perché si allontanassero dall’abitazione. Il pericolo di attirare rappresaglie squadriste nei confronti della famiglia era reale. I fascisti, infatti, alle famiglie collaborazioniste fucilavano i primogeniti. La discussione con la donna salì di tono, poi ad un cenno di Merlo, si allontanarono di qualche centinaio di metri, appena oltre il confine dei Gallina. In un canale, accanto ad una concimaia campestre, consegnarono una pala e un piccone a Mandolino, intimandogli di scavare una fossa, l’altro condannato invece si rifiutò risolutamente. Il poveretto, in preda a convulsioni, poco mancò che ci restasse anzitempo. Li massacrarono di pallottole dopo poche palate…
“Settembre, andiamo. È tempo di migrare…”. Così Gabriele D’Annunzio metteva in rima la transumanza, quando le greggi scendevano dalla montagna per il sopraggiungere dell’autunno. La transumanza si esercitava anche nel Veneto. Il mestiere di mandriani negli anni del dopoguerra lo praticavano stagionalmente pure i Gallina di Padernello quando con altri compaesani, accompagnavano gli armenti fino ai verdi pascoli di Malga Mariech (m. 1502), sopra Valdobbiadene. Emilio Gallina e il figlio Germano, poco più che tredicenne, con Gioachino e Augusto Bavaresco, e Arturo Rossi detto “Méto Nardo” partivano a metà del mese di maggio prima dell’albeggiare e s’incamminavano lestamente con le mucche in fila indiana, circa una ventina di capi, verso Vidor e S. Pietro di Barbozza. Qui solitamente sostavano per evitare che con le ore più calde gli animali si sfiancassero. A notte fonda, lasciata la polverosa strada, s’incamminavano per l’erbal fiume silente che conduceva ai pascoli di Pian Fernet. L’uso delle malghe era barattato con il latte. Due vacche erano destinate allo scopo: produrre per pagare l’affitto ai Gallina di S. Pietro di Barbozza, forse lontani parenti di quelli insediati nella campagna di Padernello. All’alpeggio si andava per risparmiare il foraggio di casa che si doveva far bastare nei mesi invernali, ma anche per la salute delle bestie che, mangiando erba e fiori in un clima salutare, si rinvigorivano e producevano un latte che era un vero nettare. Lì si udiva solo il ruminare con il suono stonato ma rilassante dei campanacci. Il mestiere di transumante richiama il nomadismo ed è antico come il mondo. Un tempo la pastorizia era un fenomeno molto diffuso anche nelle montagne venete. La caseificazione avveniva nelle malghe, accendendo il fuoco nel focolare sul quale, immerso nel fumo, stava un enorme pentolone di rame. Era una vita di sacrificio ma salutevole oltre che un’esperienza di buona convivenza. A settembre si discendeva per il tratturo antico, che da queste parti si chiama tròdo (sentiero). Ora il vivere spasmodico ha soppiantato anche questa pratica, ma la nostalgia che fece dire al D’Annunzio “Ah, perché non son io co’ miei pastori?”, quella sì… rimane ed è attualissima. Ogni inverno scendeva da Lamon un impagliatore ben noto in casa Gallina, che rimetteva a nuovo le seggiole. Girovagava per tutte le case della zona prestando la sua straordinaria manualità. Nel primo dopoguerra arrivavano anche tanti mendicanti che trovavano da pernottare nell’umido tepore della stalla adagiati sulla paglia. Non erano degli ignoranti; raccontavano tanti aneddoti ed esperienze di vita di paesi che sembravano tanto lontani; storie di guerra, di fatiche, di malattie, di disgrazie e di povertà estrema. Avevano tuttavia molta dignità e anche qualche speranza di mutare la loro condizione. Mangiavano patate e fagioli, cibi poveri ma nutrienti serviti con amorevole cura dalle donne dei Gallina, perché il buon cuore ai contadini non è mai mancato. Una sera del 1944 accadde un fatto drammatico: irruppe nella stalla dei Gallina una ventina di partigiani comandati da un certo capitano “Merlo”, trascinando due malcapitati con le mani legate dietro la schiena, prelevati nell’osteria di “Piero dea Ida” a Paese. Si trattava di un commissario fascista e di un certo “Mandolino”, così chiamato perché accompagnava le allegre cantate suonando l’omonimo strumento. Era uno sfollato da non si sa quale località del fronte, che aveva trovato accoglienza nella sala parrocchiale, di fronte alla chiesa. Andava per le osterie a suonare e cantare in cambio di qualche spicciolo. Forse nel suo repertorio aveva inserito canzoni trasgressive nei confronti della resistenza. Fatto è che nei confronti dei due, mentre gli uomini della famiglia invasa si dileguavano per i campi, nella stalla fu istituito un sommario processo e alla fine un combattente lesse la sentenza. Di morte. Da eseguirsi seduta stante. Durante le pause della lettura, per enfatizzare la drammaticità della circostanza, qualcuno caricava l’arma dando dei colpi secchi, facendo sobbalzare i due disgraziati. In casa era rimasta la sola moglie di Emilio Gallina, Rita Michelin, con i quattro figlioletti. Saputo che volevano fucilarli nella stalla, si precipitò avventatamente dalla cucina affrontando a viso aperto l’intera compagnia, diffidando i partigiani dal commettere quello che considerava un delitto. Cercò anche delle attenuanti per i due, come fosse il loro avvocato. Considerata l’impavida insistenza della donna, che aveva a fianco il figlioletto Germano di dieci anni, piangente, ipotizzavano di fucilare i due sul cortile sotto il secolare gelso e poi gettare i corpi nella vasca del percolato. Ancora una volta Rita si oppose e insistette perché si allontanassero dall’abitazione. Il pericolo di attirare rappresaglie squadriste nei confronti della famiglia era reale. I fascisti, infatti, alle famiglie collaborazioniste fucilavano i primogeniti. La discussione con la donna salì di tono, poi ad un cenno di Merlo, si allontanarono di qualche centinaio di metri, appena oltre il confine dei Gallina. In un canale, accanto ad una concimaia campestre, consegnarono una pala e un piccone a Mandolino, intimandogli di scavare una fossa, l’altro condannato invece si rifiutò risolutamente. Il poveretto, in preda a convulsioni, poco mancò che ci restasse anzitempo. Li massacrarono di pallottole dopo poche palate…
